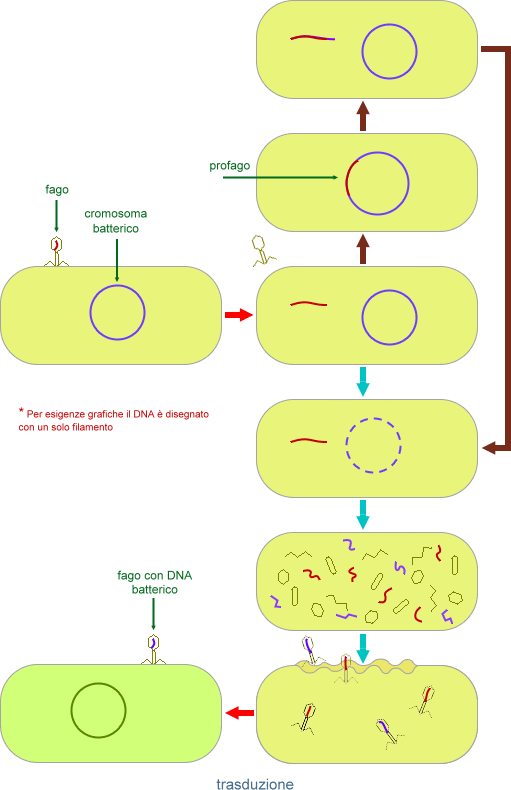La riproduzione dei virus
Abbiamo già visto che un virus contiene solo un filamento di DNA o RNA e perciò deve servirsi di una cellula ospite per la riproduzione.
La riproduzione dei virus richiede 4 momenti successivi:
- riconoscimento dell'ospite,
- infezione,
- sintesi dei componenti,
- assemblaggio delle particelle e lisi cellulare.
Riconoscimento dell'ospite
Il capside virale riconosce siti specifici presenti nella membrana cellulare dell'ospite. Poiché i siti sono diversi da organismo a organismo, possiamo individuare:
- virus batterici o batteriofagi, o fagi, che infettano i Batteri,
- virus animali, che attaccano solo gli Animali,
- virus vegetali, che colpiscono le Piante.
È molto raro il salto di specie, cioè che un virus delle piante colpisca un animale. Meno raro è il passaggio di un virus da un maiale o un pollo all'uomo.
Infezione
I virus animali generalmente penetrano con tutto il virione nella cellula, mentre nei batteriofagi entra solo l'acido nucleico e il capside, rimasto all'esterno, si decompone.
Sintesi
Il virus non possiede enzimi propri perciò sfrutta quanto messo a disposizione dall'ospite attivando innanzitutto i geni che duplicano il DNA virale e poi quelli che formano il capside.
In alcuni casi, come nei fagi, viene distrutto completamente il DNA batterico e il virus prende il controllo della cellula per la produzione delle proteine e la duplicazione dell'acido nucleico. Questo è detto ciclo litico perché porta alla morte della cellula.
In altri, il genoma virale (fagi temperati) si integra con quello batterico (Batteri lisogeni) e rimane latente anche per lunghi periodi sotto forma di profago, cioè di fago integrato nel Battere lisogeno, replicandosi insieme a quello ospite (ciclo lisogeno). Dopo moltissime divisioni e in determinate condizioni si attiva per passare al ciclo litico. Il genoma virale può anche integrarsi nella cellula eucariote. Nel caso di virus a RNA (retrovirus) l'RNA deve prima essere convertito in DNA per mezzo dell'enzima trascrittasi inversa.
Assemblaggio e lisi
Quando numerose copie di acido nucleico e di capsidi sono prodotti, avviene il montaggio dei virioni, la cellula va incontro a lisi (o a esocitosi) e i nuovi virus sono liberati nell'ambiente.

La riproduzione nei Procarioti
La cellula procariote, come abbiamo già visto in un'altra sezione, ha una struttura molto semplice e possiede un solo cromosoma ad anello, generalmente ancorato alla membrana plasmatica.
La divisione cellulare è un processo molto rapido, circa 20 - 30 minuti, ed è chiamata scissione binaria. Le condizioni ambientali e la concentrazione di sostanze nutritive fungono da segnali per l'avvio della divisione della cellula.
Innanzitutto il cromosoma, ancorato alla membrana tramite un mesosoma, si duplica con un processo che esamineremo più avanti. Anche il nuovo cromosoma si ancora alla membrana, in un punto vicino ma distinto.
La cellula cresce in lunghezza fino a raddoppiare le dimensioni per la sintesi di nuova membrana e nuova parete tra i due cromosomi, che si allontanano reciprocamente. Nello stesso tempo sono sintetizzate macromolecole e ribosomi sufficienti per due cellule.
Nella cellula si forma un anello di fibre proteiche, simili alla tubulina degli Eucarioti, tra i due punti di ancoraggio dei cromosomi che introflette la membrana fino a strozzarla progressivamente e suddividerla in due, mentre si deposita nuovo materiale a livello della parete.
Le molecole e i ribosomi sono equamente ripartiti prima della chiusura del setto trasversale di separazione.
Ora si hanno due cellule identiche, cioè due organismi, ciascuno con un cromosoma.

Il fatto di essere organismi tutti identici, rappresenta uno svantaggio in caso di cambiamento delle condizioni ambientali. I Batteri, tuttavia, possiedono anche i plasmidi, contenenti geni specifici che possono risultare utili in caso di avversità e possono essere scambiati da un individuo all'altro mediante fenomeni di ricombinazione genetica diversi dalla ricombinazione degli Eucarioti, che si verifica durante la meiosi.
Coniugazione
La coniugazione è la più importante modalità di ricombinazione e consiste nel trasferimento di DNA da un Battere a un altro mediante il contatto diretto delle cellule.
La cellula donatrice, considerata tipo maschile (F+), possiede un plasmide (F = fattore di fertilità) che contiene geni per la produzione di pili sessuali. Il pilo sessuale entra in contatto con un Battere ricevente privo di plasmide (F-), considerato di tipo femminile, e tra i due si forma il tubo di coniugazione, cioè un ponte citoplasmatico che consente il passaggio di uno solo dei due frammenti di DNA verso la cellula ricevente. Quando la cellula riceve il plasmide diventa a sua volta F+.
Il DNA di F può, in certe condizioni, inserirsi nel DNA principale e la cellula è indicata come HFR.

Trasformazione
La trasformazione è un tipo di ricombinazione che avviene per l'assorbimento, a determinate condizioni ambientali, di segmenti di DNA di cellule batteriche morte, liberi nell'ambiente, in Batteri detti competenti, cioè in grado di incorporare DNA.
Il DNA penetrato può inserirsi in parte nella cellula ospite, facendole acquisire nuove caratteristiche.
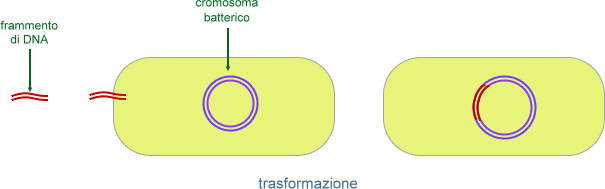
Trasduzione
Un altro meccanismo di ricombinazione genica è la trasduzione, che consiste nel trasferimento di alcuni geni da una cellula ad un'altra mediante i fagi.
Questo si verifica quando, nel ciclo litico, in un capside virale ancora vuoto si inserisce un frammento di DNA del Battere ospite, oppure quando il DNA virale, inserito durante il ciclo lisogeno nel DNA batterico (profago), si stacca in un punto sfalsato rispetto al luogo di inserimento, portando con sé geni del Battere. Se il virus neoformato infetta un'altra cellula batterica, trasferirà anche il frammento di DNA della precedente cellula.
Il trasferimento può essere casuale (trasduzione generalizzata) oppure non casuale (trasduzione specializzata) se il profago si inserisce in loci specifici.