Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono tutti quegli organismi (batteri, piante, animali), che contengono geni che sono stati manipolati.
Se il DNA proviene da una specie diversa da quella dell'ospite, si hanno organismi transgenici. Ad esempio, un gene di un insetto inserito in una pianta.
Gli organismi cisgenici, invece, derivano dal trasferimento artificiale di geni provenienti da organismi della stessa specie o da specie correlate, ad esempio, un gene di una patata selvatica inserito in una patata coltivata.
Biotecnologie rosse: Sanità
Il campo delle biotecnologie rosse è molto vasto e comprende tutti quei settori inerenti la salute dell'uomo e degli animali: farmaci, vaccini, terapie rigenerative, diagnosi, terapia genica e molto altro.
Produzione di farmaci
L'amplificazione genica consente di produrre quantità commerciali di proteine ad uso terapeutico. La somatostatina (la prima ad essere prodotta), l'insulina (la prima commercializzata), l'interferone, i fattori della coagulazione del sangue, l'eritropoietina, sono prodotti in bioreattori da Batteri GM.
Farmaci proteici possono essere prodotti non solo da Batteri ma anche da animali e piante transgeniche. In mucche, pecore e capre si inserisce un gene, con una sequenza regolatrice in modo che si esprima solo nelle mammelle, affinché producano latte con il farmaco di interesse. Questa tecnica presenta dei vantaggi perché non ci sono contaminazioni da proteine batteriche ma, oltre alle difficoltà nella manipolazione, si possono avere gravi patologie negli animali. Lo stesso si potrebbe fare con le piante: anticorpi, antigeni, enzimi ecc. che si esprimono nei frutti.
I farmaci oggi possono essere progettati a partire dall'analisi delle proteine prodotte da agenti patogeni, in modo che possano raggiungere il corretto bersaglio senza essere degradati dal sistema immunitario.
Interessante è anche la possibilità di usare farmaci a RNA, in alternativa alla terapia genica. L'RNA interference è una molecola che in natura silenzia l'mRNA, degradandolo, impedendo l'espressione di un gene difettoso e quindi la produzione di una proteina dannosa. Questo meccanismo può essere sfruttato per silenziare a monte un gene che provoca la patologia senza doverne curare gli effetti. La particolarità di questa tecnica è che si disattiva temporaneamente un gene senza modifiche dirette e permanenti sul DNA, che possono essere trasmesse ai discendenti. Con questi farmaci si potrebbero curare malattie metaboliche, degenerative, neuromuscolari, cardiovascolari e molte altre senza i problemi etici della terapia genica.
Vaccini
I vaccini prodotti dall'ingegneria genetica derivano da una piccola parte del capside virale, quella in grado di stimolare la produzione di anticorpi. Queste proteine, prodotte da Batteri GM, sostituiscono l'inoculazione dell'intero virus, che potrebbe dare reazioni avverse per la presenza dell'acido nucleico.
Oggi si sta studiando il modo di creare "vaccini edibili" cioè frutta o verdura che contiene vaccini fabbricati dalla pianta. Sono già stati esperimenti su animali con un vaccino antirabbico e contro l'ebola.
I farmaci e vaccini biotecnologici sono più specifici, più puri e meno costosi di quelli prodotti con metodiche tradizionali.
Diagnosi di malattie genetiche
Le malattie genetiche ereditarie, come l'anemia falciforme, la còrea di Huntington, la distrofia muscolare, la fibrosi cistica, sono oggi rilevabili da test genetici e, anche se al momento non esistono terapie, la loro individuazione precoce consente di limitare o controllare gli effetti dannosi di queste patologie.
Produzione di anticorpi monoclonali
Gli anticorpi monoclonali o MAb (così chiamati perché sono cloni di un'unica cellula) sono il prodotto di cellule dette ibridomi che derivano dalla fusione di linfociti B, in grado di riconoscere specifici antigeni, con cellule di mieloma, che si riproducono illimitatamente. Con questa tecnica si ottengono grandi quantità di anticorpi, specifici per ogni antigene e perciò in grado di selezionare le cellule bersaglio e raggiungerle con farmaci da essi trasportati. Oggi trovano ampia applicazione nelle terapie contro i tumori, perché essi producono antigeni superficiali non presenti in cellule sane, e in diagnostica per: gravidanze, gruppi sanguigni, antigeni di istocompatibilità, tumori, malattie, allergie, anomalie genetiche, infezioni virali e batteriche, livello di droghe, pesticidi, parassiti tropicali. Si impiegano al posto della ciclosporina per bloccare i linfociti T in caso di trapianto, onde attenuarne il rigetto e nelle malattie autoimmuni, come l'artrite reumatoide e la sclerosi multipla.
Lotta contro il cancro
Gli oncogeni sono dei geni in grado di trasformare una cellula normale in tumorale. Per evitarne lo sviluppo si può intervenire con gli anticorpi monoclonali o con RNA di regolazione che inattivano le proteine espresse dagli oncogeni, oppure si possono riattivare i geni oncosoppressori, eventualmente disattivati, tramite manipolazione genetica. Si può intervenire anche modificando i linfociti T, responsabili della risposta immunitaria specifica, in modo che riconoscano le cellule tumorali.
Fra le altre modalità di lotta abbiamo: la stimolazione del sistema immunitario con vaccini anticancro, usando piccole proteine chiamate interleuchine o il fattore di necrosi tumorale o ancora con l'endostatina, che priva le cellule del nutrimento proveniente dal sangue.
Animali transgenici come modelli di malattie umane
 La ricerca biomedica si serve spesso di animali, in particolare del topo, che condivide con l'uomo l'80% dei geni. Quando un gene che determina una malattia non è presente nel topo, si ricorre all'ingegneria genetica creando un animale transgenico. Ad esempio, il topo non soffre di anemia mediterranea, ma lo si può modificare introducendo il gene per tale malattia. Un animale molto utilizzato nelle sperimentazioni di farmaci antitumorali è l'oncotopo, un topo geneticamente modificato che è programmato per sviluppare tumori. Può essere utile anche vedere il funzionamento di gene studiandone gli effetti quando viene silenziato. Per queste ricerche si usano i topi knockout, cioè topi in cui viene soppressa l'espressione di un gene.
La ricerca biomedica si serve spesso di animali, in particolare del topo, che condivide con l'uomo l'80% dei geni. Quando un gene che determina una malattia non è presente nel topo, si ricorre all'ingegneria genetica creando un animale transgenico. Ad esempio, il topo non soffre di anemia mediterranea, ma lo si può modificare introducendo il gene per tale malattia. Un animale molto utilizzato nelle sperimentazioni di farmaci antitumorali è l'oncotopo, un topo geneticamente modificato che è programmato per sviluppare tumori. Può essere utile anche vedere il funzionamento di gene studiandone gli effetti quando viene silenziato. Per queste ricerche si usano i topi knockout, cioè topi in cui viene soppressa l'espressione di un gene.
Topi knockout
Animali transgenici per trapianti d'organo
Lo xenotrapianto è una prospettiva di ricerca particolarmente interessante, vista la cronica carenza di organi. Il maiale è l'animale che più si presta per questi esperimenti: se si riuscisse a far esprimere antigeni umani ai suoi organi se ne avrebbero in abbondanza, vista la loro prolificità.
Terapia genica
La terapia genica consiste nell'utilizzo di tecniche di DNA ricombinante per sostituire un gene difettoso con uno sano o per affiancarlo con uno funzionante (transfettare o trasfettare), o ancora per impedire al gene difettoso di esprimersi.
Il trasferimento genico, può essere fatto con diverse metodologie:
- iniezione di DNA nudo, cioè inserire direttamente il DNA con una micropipetta, ma purtroppo occorrerebbe farlo per ogni singola cellula;
- uso della pistola genica, che presenta lo stesso problema del metodo precedente;
- uso di liposomi, sferette a doppio strato fosfolipidico contenenti il gene di interesse, ma risultano poco efficaci; analogo è il metodo dei polimeri cationici;
- impiego dei virus: vista la loro tendenza ad infettare le cellule inserendovi il proprio DNA, hanno un'efficienza maggiore rispetto ai metodi precedenti; i virus devono essere opportunamente modificati in modo da perdere il potere patogeno senza diminuire la capacità infettante; quando il virus penetra nella cellula può integrarsi con quello dell'ospite e ciò consente la replicazione e la trasmissione alle cellule figlie oppure può rimanere all'esterno sotto forma di particella episomiale e, non replicandosi, non si trasmette alle cellule figlie, a meno che non venga dotata di un'origine della replicazione; attualmente i più usati sono i retrovirus.
Esistono due tipologie di terapia genica: la prima agisce sulle cellule germinali, la seconda sulle cellule somatiche.
La terapia genica delle cellule germinali si effettua sulla cellula uovo, sullo spermatozoo o sull'embrione nei primi stadi di sviluppo. La modifica si trasmette su tutte le cellule dell'individuo e poi passa anche alla discendenza. Questa tecnica presenta risvolti etici importanti e per questo attualmente non è praticata.
La terapia genica delle cellule somatiche consiste nella trasfezione di cellule differenziate; essa rimane confinata a quelle che ricevono il materiale genetico e non si trasmette alla prole. In pratica è una terapia da considerare analoga a un trapianto di organo o di tessuto.
La terapia genica somatica è a sua volta suddivisa in due categorie: "ex vivo" e"in vivo".
La terapia ex vivo consiste nel prelevare alcune cellule somatiche malate del paziente, coltivarle in vitro, transfettarle con un vettore opportunamente preparato e poi reinserirle nel paziente. La tecnica è lunga e costosa.
La terapia in vivo consiste nell'inserimento del vettore direttamente nel paziente tramite un'iniezione per via locale nella porte da trattare oppure per via sistemica, cioè nel circolo sanguigno. Si applica quando non è possibile prelevare le cellule, specialmente quelle degli organi come il cuore e il cervello. La tecnica è più rapida ed economica della precedente ma più difficile da applicare.
La terapia genica potrebbe rappresentare una cura definitiva a tutte le gravi patologie che attualmente non sono trattabili con i metodi tradizionali. Purtroppo presenta notevoli difficoltà di applicazione e dà spesso risultati insoddisfacenti e questo perché ci sono ancora diversi limiti da superare: il vettore deve essere in grado di riconoscere le cellule bersaglio senza essere attaccato dal sistema immunitario; il gene si deve integrare nel genoma ed esprimersi correttamente; si deve sostituire il gene difettoso in milioni di cellule.
Cellule staminali
Le cellule staminali sono cellule indifferenziate in grado di trasformarsi in molti tipi cellulari diversi attraverso il differenziamento cellulare, in risposta ad uno stimolo. Si trovano nel midollo osseo, nella placenta, nel cordone ombelicale, nel tessuto adiposo, nel cervello e nella polpa dentaria.
Sono attive a partire dallo zigote, che deve generare l'intero individuo mentre nell'adulto consentono di sostituire le cellule morte o danneggiate.
Queste cellule si possono replicare illimitatamente senza mutare lo stadio di indifferenziate. Quando devono differenziarsi, si ha una divisione cellulare asimmetrica in cui una cellula si specializza mentre l'altra rimane indifferenziata. In questo modo si ha sempre una riserva di cellule staminali.
Possono essere suddivise nelle seguenti categorie in base alla potenzialità di differenziarsi.
- Cellule totipotenti: possono trasformarsi in qualsiasi tipo di cellula e generare un individuo completo; è il caso dello zigote. Le cellule vegetali differenziate, se coltivate in vitro, possono ritornare totipotenti.
- Cellule pluripotenti: possono trasformarsi nei derivati di uno dei tre foglietti embrionali (ectoderma - tessuti epidermici e sistema nervoso -, mesoderma - tessuti muscolo-scheletrici, sangue, urogenitale -; endoderma - tessuti dell'apparato digerente e polmonare -) ma non possono generare un intero individuo né le cellule dei tessuti extra-embrionali. A questo gruppo appartengono le cellule staminali embrionali.
- Cellule staminali multipotenti. Sono le cellule staminali adulte e tessuto-specifiche, presenti nei diversi tessuti del feto e dell'organismo adulto. Possono differenziarsi in pochi tipi cellulari ma appartenenti al tessuto di cui fanno parte, come la staminali emopoietiche che danno origine ai vari tipi di cellule del sangue.
- Cellule unipotenti: possono trasformarsi in un solo tipo cellulare, come gli epatociti e lo strato germinativo dell'epidermide.
Le cellule staminali embrionali sono quelle che si trovano nell'embrione nei primissimi stadi di sviluppo e danno origine a tutti i tessuti e organi dell'individuo. Sono dotate di alta capacità di proliferazione anche in vitro e possono originare qualsiasi tessuto o organo (pluripotenti) e ciò le rende particolarmente adatte all'uso terapeutico mediante modificazione genetica. Tuttavia, possono essere prodotte solo generando embrioni in vitro e questo comporta importanti problemi etici.
Le cellule staminali adulte sono presenti in piccolo numero nei tessuti per garantire il ricambio cellulare, soprattutto in quelli che hanno maggiore necessità rigenerativa. Esse sono generalmente difficili da isolare e amplificare in coltura e hanno una minore capacità di differenziazione ma sono più facilmente inducibili rispetto alle cellule staminali embrionali mediante l'aggiunta di specifici fattori. Queste cellule possono essere utilizzate senza particolari problemi di rigetto in quanto ottenute dallo stesso paziente e non presentano problemi etici.
Le cellule staminali fetali, sono quelle isolate dal cordone ombelicale, dalla placenta e dal liquido amniotico e quindi non presentano particolari problemi etici. Come le adulte, sono cellule multipotenti in quanto presenti nei tessuti già specializzati, ma hanno una maggiore plasticità, che le rende più adatte per un approccio terapeutico. La difficoltà riguarda il fatto che non si possono usare cellule provenienti dal paziente stesso, a meno che non sia stato conservato alla nascita il cordone ombelicale.
Oggi è possibile ottenere cellule staminali da cellule somatiche differenziate, come i fibroblasti, riprogrammandole mediante l'introduzione di vettori di espressione che sono presenti nelle cellule staminali embrionali. Queste cellule, dette iPSC (cellule staminali pluripotenti indotte) possono poi differenziarsi in qualsiasi tipo cellulare e trovano impiego nella rigenerazione di tessuti o per la correzione di difetti genetici. In questo caso, si preleva dal paziente la cellula con un gene difettoso, la si porta a uno stadio indifferenziato, si corregge il gene, la si fa differenziare per poi infonderla nel paziente.
Anche organi interi potrebbero in teoria essere ricreati con queste cellule senza avere il problema del rigetto perché derivano dal paziente stesso.
Le cellule staminali presentano dunque grandi potenzialità per la cura di numerose patologie, tra cui il diabete, le retinopatie, le malattie neurodegenerative, le malattie genetiche rare.
Medicina rigenerativa
Le moderne biotecnologie hanno consentito di ampliare le conoscenze sui geni e proteine coinvolti nello sviluppo delle malattie neurovegetative. Queste malattie sono dovute all'alterazione della struttura tridimensionale delle proteine, che provoca la morte dei neuroni perché si accumulano senza essere eliminate, con conseguenti danni a livello motorio (Parkinson) o cognitivo-mnemonico (Alzheimer - encefalopatia spongiforme).
La medicina rigenerativa è impegnata nello sviluppo di test diagnostici e nel predisporre nuovi approcci terapeutici.
Per quanto riguarda la malattia di Parkinson, ci sono prospettive terapeutiche con l'uso delle iPSC e con la terapia genica, utilizzando un farmaco basato su un virus modificato, in grado di infettare i neuroni per far loro produrre la dopamina di cui necessita il paziente.
Per la malattia di Alzheimer e le encefalopatie spongiformi, le ricerche riguardano prevalentemente farmaci sintomatici, senza essere però in grado di modificare il decorso naturale della malattia.
Nel campo della medicina rigenerativa rientra anche l'ingegneria dei tessuti. Si tratta di ricostruire un tessuto o un organo utilizzando cellule del paziente, abbinate a molecole bioattive e a biomateriali naturali o sintetici. Questa tecnica risolverebbe i problemi della carenza di organi per i trapianti e i problemi di rigetto.

Cellule embrionali di topo
Biotecnologie verdi: Agricoltura
Le biotecnologie verdi sono quelle tecniche ampiamente applicate nelle colture vegetali per la grande capacità che i vegetali possiedono nel generare un'intera pianta da una singola cellula già differenziata (totipotenza). In generale, comunque, riguardano tutti i processi del settore agricolo.
Con l'ingegneria genetica si possono creare diversi tipi di piante.
Piante resistenti alle malattie
Per malattie virali, dove gli interventi chimici e biologici non arrivano, sono stati fatti diversi esperimenti con metodi di resistenza transgenica indotta da proteine o da RNA, anche se poche specie sono entrate in commercio, come il susino e la papaya. Oltre alla transgenesi, si può impiegare la cisgenesi, che consente di avere gli stessi risultati del tradizionale miglioramento genetico, ma ottenuti in minor tempo e con poca spesa. Un altro metodo non transgenico si ha con l'impiego di piccoli frammenti di RNA in grado di silenziare o modulare l'espressione di alcuni geni di interesse. La loro mobilità consente di raggiungere tutte le parti della pianta. Il prodotto non è quindi GM ma protetto da molecole ad azione specifica contro parassiti e patogeni. Anche microorganismi possono essere usati per la resistenza, come funghi antagonisti in grado di proteggere le radici da altri funghi patogeni.
Piante resistenti agli insetti nocivi
Da diversi anni si usano come insetticidi le tossine Bt prodotte dal Bacillus thuringiensis, che sono tossiche per le larve di molti Insetti ma non per gli animali e per l'uomo. Alcune piante (mais, cotone, soia) sono state geneticamente modificate affinché possano produrre autonomamente queste tossine. L'uso massiccio di questi prodotti potrebbe però indurre la comparsa di forme di resistenza negli Insetti.
Piante resistenti agli erbicidi
L'inserimento di un gene che resiste al glifosato o altro erbicida in una pianta utile, consente l'uso dell'erbicida senza danneggiarla. Questa tecnica è molto usata per la soia, la colza e l'erba medica, ma presenta due inconvenienti: l'immissione di grandi quantità di prodotti chimici nell'ambiente e la possibilità di trasmettere la resistenza alle piante infestanti.
Piante che si conservano a lungo
Molte verdure possono subire danni durante lo stoccaggio e il trasporto o subire una maturazione molto rapida. Sono stati creati dei pomodori nei quali è stato bloccato un gene per la sintesi di dell'etilene, che li farebbe maturare rapidamente.
Piante autofertilizzanti
L'inserimento di un gene che consentisse la fissazione dell'azoto, analogo alla simbiosi delle Leguminose, farebbe risparmiare una grande quantità di fertilizzanti. Si potrebbe anche modificare i microorganismi simbionti azotofissatori in modo da aumentarne le loro capacità o adattarli anche ai cereali.
Piante con proprietà nutrizionali particolari
È stato prodotto un tipo di riso transgenico, il Golden rice, che esprime un gene per la produzione di beta carotene, precursore della vitamina A, prelevato dalla giunchiglia. Questo alimento potrebbe parzialmente risolvere il problema della malnutrizione nelle popolazioni che si nutrono solo di riso raffinato. Anche il pomodoro blu (o nero), ottenuto sia con la tradizionale selezione che con l'ingegneria genetica, presenta caratteristiche alimentari interessanti in quanto ricco di antociani, sostanze antiossidanti.

Pomodoro SunBlack
Piante con qualità dei prodotti migliorate
Sono state sviluppate patate con più amido che non anneriscono al taglio e non assorbono l'olio di frittura, uva senza semi, meloni che sopportano l'acqua di mare, frutta e verdura con più vitamine, foglie di legumi che accumulano proteine, melanzane presenti in tutte le stagioni senza fecondazione, caffè senza caffeina.
Piante resistenti a stress ambientali
Salinizzazione del suolo, siccità e gelo sono problemi che affliggono diverse aree del mondo.
Per l'eccessiva salinità sono stati fatti esperimenti sul tabacco con geni di E. coli che producono sostanze osmoregolatrici,
Anche per la siccità si è ricorso all'uso di geni di E. Coli per la produzione del disaccaride trealosio, che stabilizza le proteine di membrana.
La resistenza al gelo può essere fornita dall'inserimento di un gene per le proteine anticongelamento dei pesci d'acqua fredda, oppure da batteri normalmente presenti sulla superficie delle piante modificati in modo da impedire la formazione di ghiaccio. Esperimenti sono stati fatti anche su tabacco che esprime geni di Arabidopsis per la produzione di acidi grassi insaturi.
Le piante GM presentano comunque alcuni aspetti problematici, in parte già accennati qui sopra. Fra gli altri rischi citiamo il fatto che come marcatori dei vettori si usano spesso geni per l'antibiotico-resistenza, che potrebbero trasferirsi agli animali e all'uomo. C'è il rischio di una riduzione della biodiversità con la scomparsa di molte specie vegetali autoctone.
L'inserimento di geni esogeni potrebbe creare effetti non immediatamente visibili, come lo scatenarsi di reazioni allergiche o l'attivazione di altri geni che normalmente sono silenti, con conseguenti modifiche metaboliche non prevedibili.
Gli OGM, inoltre, hanno un costo che potrebbe essere non sostenibile per i Paesi poveri.
Biotecnologie in zootecnia
Questo settore non è identificato con un particolare colore perché gran parte dei prodotti biotecnologici rientrano nelle altre categorie. Solo per completezza aggiungiamo alcune informazioni.
Un animale transgenico è più difficile da produrre rispetto ad una pianta perché questa si può ricreare da una qualsiasi sua parte, mentre per l'animale occorre l'uovo fecondato o un embrione nei primi stadi di sviluppo. Inoltre, tollerano molto meno la manipolazione genetica e spesso presentano varie patologie.
Gli obiettivi in zootecnia sono i medesimi di quelli per l'agricoltura: produzione di animali da allevamento più resistenti alle malattie e alle infezioni; ottenere prodotti animali, come carne, latte, uova con una composizione modificata per renderli più salubri (carne più magra ...).

Biotecnologie blu: Ambienti acquatici
Le biotecnologie blu riguardano le tecniche rivolte ad organismi marini e di acqua dolce per ricavare nuovi materiali e prodotti. Ad esempio, dalle alghe si può ricavare l'acido alginico da impiegare nell'industria alimentare come addensante, cosmetica, farmaceutica (preparati contro il reflusso gastroesofageo). Gli integratori alimentari (chitosani, olio di fegato, enzimi, amminoacidi) si possono ottenere da animali marini. Di particolare interesse è la ricerca di nuove molecole da usare come marcatori per la diagnostica e come farmaci. È già in uso un farmaco antitumorale dal tunicato Ecteinascidia turbinata. Si possono anche studiare soluzioni per limitare il proliferare di specie dannose per l'habitat e l'uomo.

Biotecnologie marrone: Deserto
La biotecnologia marrone si occupa della gestione, dello studio e della ricerca in aree desertiche di potenziali risorse, come nuove molecole di interesse. Riguarda anche la sperimentazione di semi resistenti su terreni siccitosi e salini. In questo si avvicina alla biotecnologia verde e grigia.

Biotecnologie grigie: Ambiente
Le biotecnologie grigie comprendono tutte quelle tecniche che impiegano organismi viventi per la salvaguardia ambientale e la tutela della biodiversità.
La protezione ambientale comporta l'individuazione di processi produttivi rispettosi dell'ambiente, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti e il risanamento delle aree inquinate.
I processi produttivi più all'avanguardia si propongono di evitare l'uso di sostanze pericolose per l'ambiente, come metalli pesanti, solventi ecc. e la loro dispersione, sostituendoli preferibilmente con materie prime di origine vegetale rinnovabili. Di particolare interesse è l'impiego di biocombustibili, meno inquinanti di quelli tradizionali.
La biotecnologia ambientale si occupa anche del trattamento, del riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti, in particolare di quelli organici e dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, tramite la digestione anaerobica con produzione di biogas o con il compostaggio aerobico, da utilizzare poi come fertilizzante.
Il biorisanamento consiste nel ripristino delle condizioni di vivibilità ambientale ripulendo l'ambiente da inquinanti come idrocarburi, metalli pesanti e sostanze radioattive, con la depurazione delle acque reflue, abbattendone il carico di azoto e fosforo, e con la biofiltrazione delle emissioni gassose. Il petrolio greggio fuoriuscito da piattaforme o petroliere può essere degradato da alcuni Batteri GM; altri Batteri, molto resistenti alle alte temperature, sono utilizzati per lo spostamento del greggio nei giacimenti petroliferi in via di esaurimento. I metalli pesanti, come lo zinco, il rame, il cadmio possono essere rimossi tramite Batteri modificati che esprimono una proteina in grado di assorbirli. Anche alcune piante GM possono svolgere la medesima funzione. La stessa procedura può essere attuata per i fosfati. Come per il petrolio, i Batteri si possono usare per l'estrazione dei minerali, poiché ne favoriscono il passaggio in soluzione. Il biorisanamento è perciò fondamentale perché consente il riuso dei materiali dispersi nell'ambiente.
La salvaguardia della biodiversità si attua attraverso l'analisi genetica delle popolazioni di un ecosistema e la clonazione di specie in pericolo di estinzione.

Biotecnologie bianche: Industria
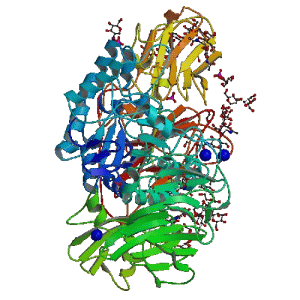 Le biotecnologie industriali si servono di mezzi biologici per la produzione di un prodotto commerciale con un costo minore in termini di risorse materiali, energetiche e di inquinamento rispetto ai metodi tradizionali e quindi con maggiore efficienza e sostenibilità.
Le biotecnologie industriali si servono di mezzi biologici per la produzione di un prodotto commerciale con un costo minore in termini di risorse materiali, energetiche e di inquinamento rispetto ai metodi tradizionali e quindi con maggiore efficienza e sostenibilità.
L'applicazione principale riguarda la produzione e l'impiego di enzimi per accelerare le reazioni chimiche e aumentarne la resa, con un notevole risparmio energetico e di tempo in quanto agiscono in condizioni blande di temperatura, pressione e pH, riducendo anche gli scarti inquinanti e il consumo di acqua. Gli enzimi si usano nella forma naturale o modificati con l'ingegneria genetica.
I settori interessati sono molteplici e si intersecano con gli altri "colori" delle biotecnologie. Ad esempio, le xilanasi prevengono la formazione di derivati tossici dalla lignina nella fabbricazione della carta; le proteasi si usano per scindere le proteine del latte per neonati o nel campo dei detersivi; le beta-galattosidasi rendono il latte più digeribile; pectinasi si usano per la chiarificazione dei succhi di frutta; lipasi per migliorare la panificazione. Nel campo energetico la ricerca riguarda la produzione di biodisel e di bioelettricità mediante Batteri.
Biopolimeri di varia natura e plastica biodegradabile derivate da vegetali come il mais, il grano e le patate, rientrano nelle biotecnologie bianche Un biopolimero polisaccaridico, attualmente molto usato in diversi tipi di farmaci e cosmetici, è l'acido ialuronico, ottenuto dalla fermentazione di batteri del genere Streptococcus.
Beta-galattosidasi
Biotecnologie gialle: Alimenti
 Questo ramo delle biotecnologie, parzialmente in comune con le biotecnologie bianche e verdi, riguarda l'uso degli organismi viventi o dei loro derivati nel campo dell'alimentazione. Lo scopo è di migliorare alcuni prodotti alimentari rendendoli più salubri o più ricchi dal punto di vista nutrizionale. Gli ambiti riguardano principalmente la qualità dei prodotti, la produzione di alimenti e i processi di trasformazione.
Questo ramo delle biotecnologie, parzialmente in comune con le biotecnologie bianche e verdi, riguarda l'uso degli organismi viventi o dei loro derivati nel campo dell'alimentazione. Lo scopo è di migliorare alcuni prodotti alimentari rendendoli più salubri o più ricchi dal punto di vista nutrizionale. Gli ambiti riguardano principalmente la qualità dei prodotti, la produzione di alimenti e i processi di trasformazione.
La qualità degli alimenti è valutata usando le moderne analisi basate su anticorpi monoclonali e sonde geniche, seguendo la filiera nella ricerca di eventuali sostanze contaminanti o tossiche di origine chimica a fisica, in grado di influire sulle qualità organolettiche dei cibi.
Oltre alla produzione di composti alimentari di cui abbiamo accennato nelle biotecnologie bianche, si producono cibi particolari per persone con problemi di salute come i celiaci, gli intolleranti al latte, gli obesi o, viceversa con problemi di malnutrizione, rispettivamente riducendo l'apporto di grassi saturi o incrementando l'apporto calorico e vitaminico. Si cerca di eliminare allergeni e altri componenti dagli alimenti, che sono alla base di varie intolleranze. Si producono amminoacidi, come il triptofano, da usare come integratori per l'uomo e gli animali da allevamento se l'apporto con i batteri naturali non è sufficiente.
Anche i processi di trasformazione possono essere migliorati selezionando ceppi batterici con particolari caratteristiche o modificandoli geneticamente per ridurre eventuali danni di tipo termico, meccanico e chimico durante il processo di lavorazione. Queste tecniche si usano, ad esempio, per il controllo della coagulazione della caseina del latte nella preparazione dei formaggi o nella selezione e manipolazione dei lieviti per la produzione di bevande fermentate. Anche nella panificazione si usano lieviti ingegnerizzati per una lievitazione più rapida.
Biotecnologie oro: Bioinformatica
La biotecnologia oro riguarda la bioinformatica, sia software che hardware, utilizzata nell'analisi dei dati nei processi biologici. In particolare, si occupa del sequenziamento del genoma, creazione di primer, nanobiotecnologia e tecnologia dei chip, ricerca di errori nel DNA, analisi filogenetica, simulazione di processi biologici, creazione di banche dati di informazioni biologiche, genomica funzionale e strutturale, proteomica. Ne riparliamo nella pagina successiva.

Biotecnologie viola: Legalità ed Etica
 Le biotecnologie viola si occupano degli aspetti legali ed etici relativi a questa scienza. In particolare riguardano le misure di sicurezza (biosicurezza), la regolamentazione legale dei brevetti, le leggi sugli OGM, l'impatto etico di alcune tecnologie (terapia genica germinale, fecondazione assistita, sperimentazione su animali e uomo, clonazione).
Le biotecnologie viola si occupano degli aspetti legali ed etici relativi a questa scienza. In particolare riguardano le misure di sicurezza (biosicurezza), la regolamentazione legale dei brevetti, le leggi sugli OGM, l'impatto etico di alcune tecnologie (terapia genica germinale, fecondazione assistita, sperimentazione su animali e uomo, clonazione).
Biotecnologie arancione: Informazione
La biotecnologia arancione si occupa della formazione e della diffusione delle conoscenze, e delle applicazioni e delle scoperte nel campo biotecnologico, smascherando le fake che le circondano.

Biotecnologie nere: Bioterrorismo
 Le biotecnologie non vengono purtroppo sempre indirizzate alla produzione di beni e servizi utili, ma anche per attentare o minacciare l'incolumità pubblica seminando panico, malattie e morte nella popolazione, al fine di rivendicazioni politiche, religiose o economiche.
Le biotecnologie non vengono purtroppo sempre indirizzate alla produzione di beni e servizi utili, ma anche per attentare o minacciare l'incolumità pubblica seminando panico, malattie e morte nella popolazione, al fine di rivendicazioni politiche, religiose o economiche.
Virus, batteri e tossine si possono reperire in natura o possono essere modificati dall'uomo per aumentare la virulenza e la diffusione dei patogeni o rendere patogeni organismi innocui. Sono sufficienti cinque modificazione genetiche al virus dell'influenza aviaria H5N1 per renderlo facilmente trasmissibile e in grado di uccidere centinaia di milioni di persone, oppure la modifica di una Battere presente nella normale flora intestinale può renderlo in grado di produrre tossine: se entra nell'organismo non viene riconosciuto come patogeno dalle difese immunitarie e può produrre le sue tossine senza ostacoli.
Queste armi batteriologiche possono essere veicolate attraverso la contaminazione di acqua, cibi, bevande, o diffusi nell'ambiente e nell'aria.
Gli agenti più quotati per il bioterrorismo internazionale sono il vaiolo, la peste e l'antrace. Purtroppo esistono casi di contaminazione volontaria con questi patogeni o anche accidentali per la fuoriuscita da installazioni militari.
Le stesse biotecnologie possono tuttavia essere anche impiegate per rilevare e contrastare gli effetti delle armi biologiche.
Un soldato statunitense con maschera anti-nucleare, biologica e chimica M-17

