Molti caratteri sembrano apparentemente non seguire le regole combinatorie delle leggi di Mendel. Vediamo qualche caso.
Dominanza incompleta
Incrociando piante omozigoti dominanti a fiori rossi con omozigoti recessivi a fiori bianchi di Bocca di leone (Antirrhinus majus) o di Bella di notte (Mirabilis jalapa), gli ibridi della F1 hanno un fenotipo rosa, intermedio tra i due genitori, si ha cioè la dominanza incompleta.
Diversamente dalla dominanza completa, è possibile distinguere gli eterozigoti dagli omozigoti per il loro fenotipo.

Mirabilis jalapa
Apparentemente sembra violata la legge sull'uniformità degli ibridi e i caratteri appaiono mescolati. Tuttavia, se lasciamo che gli ibridi si autofecondino, alla F2 ricompaiono, oltre ai fiori rosa, anche fiori bianchi e rossi il cui numero di genotipi è in rapporto 1 : 2 : 1, uguale al numero dei fenotipi.
Questo si verifica perché il pigmento prodotto dall'allele dominante non è sufficiente da solo a dare un fenotipo pieno, che si manifesta solo in presenza dei due alleli dominanti contemporaneamente.

Nell'uomo un esempio di dominanza incompleta è il tipo di capelli, che dipende dalla forma del follicolo da cui crescono. Se è tondo (rr) i capelli sono lisci, ondulati (Rr) con foro ovale e ricci (RR) con foro a fessura.
Codominanza
Nel caso della codominanza i due alleli si manifestano contemporaneamente e completamente perché entrambi codificano proteine efficienti, anche se dotate di proprietà diverse. Il fenotipo dell'eterozigote è la somma della produzione dei due alleli.
È il caso dei gruppi sanguigni del sistema A, B, 0, che trattiamo nel paragrafo seguente. A e B sono dominanti su 0 ma tra loro sono codominanti e si manifestano contemporaneamente.
Allelia multipla
Finora abbiamo visto che un gene mostra due alleli con caratteristiche alternative. In realtà si hanno frequentemente più di due alleli per lo stesso gene. Nel sistema A, B, 0, di cui abbiamo appena detto sopra, il gene che produce antigeni sulla superficie dei globuli rossi (I) presenta gli alleli IA, IB, i. L'allele IA produce l'antigene A, IB l'antigene B e i non produce nessun antigene.
Anche se gli alleli sono tre, ogni individuo ne possiede comunque due con le sei combinazioni mostrate nella tabella sottostante, che determinano quattro fenotipi: A, B, AB, 0.
| Genotipo | Fenotipo | Anticorpi | Donare | Ricevere |
|---|---|---|---|---|
| IAIA - IAi | A | Anti-B | A - AB | A - 0 |
| IBIB - IBi | B | Anti-A | B - AB | B - 0 |
| IAIB | AB | Nessuno | AB | A - B - AB - 0 |
| ii | 0 | Anti-A e Anti-B | A - B - AB - 0 | 0 |
L'organismo, in base agli antigeni posseduti, produce anticorpi contro gruppi sanguigni diversi, per questo bisogna verificare attentamente il proprio gruppo sanguigno prima di donare o ricevere il sangue. Un errore si dimostra fatale. Il gruppo 0 è donatore universale e AB ricevitore universale.

Eredità poligenica
Quando il medesimo fenotipo è espresso da due o più geni si parla di eredità poligenica. Ciascun gene, con i suoi alleli dominanti contribuisce sommativamente al fenotipo. Si tratta di uno dei casi di interazione genica. Altri ne vedremo più avanti.
Ne sono esempi tutte quelle caratteristiche che presentano una gradazione, o variazione continua, come la statura, il peso, il colore degli occhi, della pelle, ecc.

Pleiotropia
Molti geni non determinano un solo carattere, ma manifestano più effetti fenotipici contemporaneamente, apparentemente non correlati tra loro: è la pleiotropia. Per questo, una mutazione su uno di questi geni può avere molteplici danni sull'individuo.

Diverse patologie sono legate a effetti pleiotropici. La fibrosi cistica, ad esempio, responsabile di una produzione anomala di muco, ha effetti nell'apparato respiratorio, digerente, riproduttore; l'anemia falciforme provoca febbre, danni a diversi organi, infezioni, reumatismi, ingrossamento della milza e molto altro.
Interessante è il caso di gatti bianchi che hanno un occhio verde e uno azzurro e sono sordi, in genere dalla parte dell'occhio azzurro. Il gene pleiotropico controlla la produzione di melanina dai melanociti, che viene distribuita sul pelo e sull'iride Un gruppo di melanociti è presente anche lungo il nervo acustico. Da qui la sordità e la mancanza di pigmentazione.

Interazione genica
Quando un carattere è controllato da due o più coppie di alleli, la loro interazione può far comparire fenotipi completamente nuovi.
La forma della cresta del gallo è regolata da due geni: il primo (R) dà la forma a rosa e il secondo (P) la forma a pisello quando c'è almeno un allele dominante di uno o l'altro gene; se tutti gli alleli sono recessivi otteniamo una cresta semplice. Tuttavia, la presenza contemporanea di alleli dominanti per entrambe le coppie induce la formazione di un nuovo fenotipo: la cresta a noce.
| genotipo | fenotipo | |
|---|---|---|
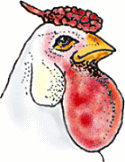 | RRpp - Rrpp | Cresta a rosa |
 | rrPP - rrPp | Cresta a pisello |
 | rrpp | Cresta semplice |
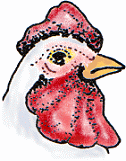 | R_P_ | Cresta a noce |
Epistasi
L'epistasi è un altro esempio di interazione genica, in cui non compaiono però nuovi fenotipi. Un gene, detto epistatico, interferisce sull'espressione fenotipica di un altro gene, definito ipostatico.
L'epistasi si differenzia dalla dominanza perché riguarda l'interazione tra alleli di due geni diversi, mentre la dominanza è l'interazione di due alleli dello stesso gene.
Si può avere un'epistasi recessiva quando una delle due coppie di geni è omozigote recessiva, epistatica sull'altra, e un'epistasi dominante quando la presenza di un solo allele dominante in una delle due coppie impedisce agli alleli dell'altra coppia di esprimersi.
Un caso di epistasi recessiva è il colore del pelo del cane Labrador, determinato dal gene B, che specifica la produzione di melanina, e il gene E che ne controlla la distribuzione sul mantello. Anche se viene prodotta la melanina, la presenza di ee ne impedisce la distribuzione sul pelo e il cane è di colore giallo. Il gene E è epistatico su B, perciò l'assenza dell'allele dominante E (ee) impedisce l'espressione del gene ipostatico (BB, Bb, bb).
| genotipo | fenotipo |
|---|---|
| BBEE - BBEe | nero |
| BbEE - BbEe | nero |
| BBee - Bbee | giallo |
| bbEE - bbEe | marrone |
| bbee | giallo |
Se incrociamo BbEe x BbEe la segregazione è quella regolare di un diibrido per quanto riguarda il genotipo ma nei fenotipi abbiamo la proporzione 9 : 3 : 4 invece di 9 : 3 : 3 : 1.

Il mantello bianco, nero e marrone delle pecore è invece un esempio di epistasi dominante. Il gene B codifica per l'assenza (B dominante) o presenza (b recessivo) di colore e il gene N codifica per il nero (N dominante) o marrone (n recessivo). Il gene B è epistatico su N e la presenza di un solo alle B (assenza di colore) impedisce alle pecore di essere nere o marrone.
| genotipo | fenotipo |
|---|---|
| BBNN - BBNn | bianco |
| BbNN - BbNn | bianco |
| BBnn - Bbnn | bianco |
| bbNN - bbNn | nero |
| bbnn | marrone |
Se incrociamo BbNn x BbNn la segregazione è quella del diibrido per quanto riguarda il genotipo ma nei fenotipi abbiamo la proporzione 12 : 3 : 1 invece di 9 : 3 : 3 : 1.
Geni e ambiente
In passato si pensava che i geni si manifestassero sempre completamente nel fenotipo. Oggi si riconosce un ruolo importante all'influenza dell'ambiente interno o esterno. Anche individui genotipicamente identici, come i gemelli monoovulari, presentano piccole differenze, così come le malattie ereditarie si presentano con fenotipi diversi a seconda dell'individuo. Per questo non sempre l'organismo riflette la sua costituzione genetica. In particolare si possono notare due tipi di effetti.
La penetranza è la frequenza con cui un genotipo manifesta il fenotipo atteso all'interno della popolazione. Se la penetranza è incompleta, alcuni individui eterozigoti manifestano il fenotipo recessivo, probabilmente a causa di fattori ambientali. Con una malattia autosomica dominante alcuni eterozigoti sono sani.
L'espressività è l'intensità con cui si manifesta un certo fenotipo. Così una malattia genetica può presentarsi in una forma più o meno grave o il colore giallo dei piselli può avere diversa intensità, ma sempre nettamente identificabile.
Facciamo alcuni esempi. Se una persona possiede un gene che induce all'obesità, non è detto che necessariamente diventi obesa. La crescita in un ambiente con carenza qualitativa o quantitativa di cibo non consente la manifestazione di questa caratteristica. La presenza di un gene per una determinata patologia in un individuo non significa che esso debba necessariamente svilupparla. Molto importante è l'esposizione a determinati stimoli ambientali e lo stile di vita.
La produzione di latte nelle mucche o di uova nelle galline dipende più dall'ambiente che dalla costituzione genetica.
Le ortensie cambiano il colore in base al pH: sono rosse con pH basico e blu con pH acido. Le piante risentono molto dei fattori ambientali come la luce, la temperatura, la disponibilità di nutrienti ecc.

Nei gatti siamesi e nei conigli himalayani la produzione di melanina, che determina il colore scuro del pelo, è stabilita geneticamente, ma influenzata dall'ambiente. Infatti, il gene si esprime completamente solo nelle parti più fredde del corpo e cioè il muso e le estremità delle zampe, della coda e delle orecchie sono scure, mentre le restanti parti sono più chiare.

Infine, nella manifestazione del fenotipo entra in gioco anche il caso. Durante lo sviluppo embrionale possono accadere eventi casuali che originano effetti diversi, anche nei gemelli monozigoti.

